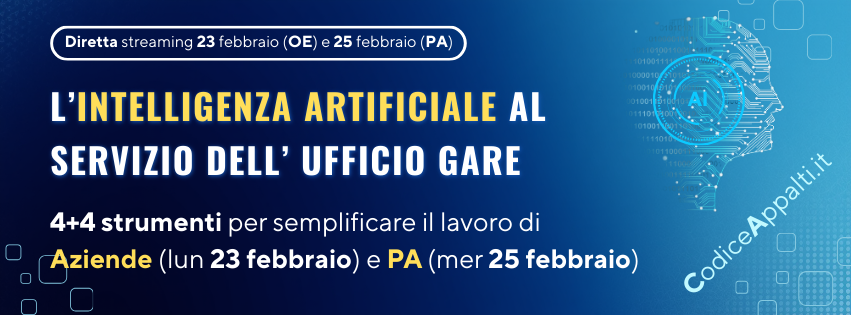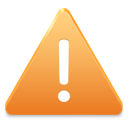SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE E APPALTO DI SERVIZI - DIFFERENZE
La giurisprudenza ha già avuto modo di indagare in concreto la natura della somministrazione di personale e delinearne i tratti distintivi dal contratto di appalto di servizi evidenziando, tra l’altro il “fatto che attraverso il contratto di appalto una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro - secondo lo schema dell’obbligazione di risultato; nel contratto di somministrazione, al contrario, l’agenzia invia in missione dei lavoratori, che svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore - secondo lo schema dell’obbligazione di mezzi”, con la conseguenza che “nel contratto di appalto i lavoratori restano nella disponibilità della società appaltatrice, la quale ne cura la direzione ed il controllo; nella somministrazione è invece l’utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le direttive da eseguire” (Cons. Stato, III, 12 marzo 2018, n. 1571).
Essendo lo schema tipico della “somministrazione di lavoro” a tempo determinato caratterizzato dalla ricerca di lavoratori da utilizzare per gli scopi del committente, risulta evidente la differenza delle prestazioni rese dalle agenzie del lavoro, quali somministratrici di personale, da quelle rese dalle imprese appaltatrici di altri servizi.
In particolare, trattandosi di prestazioni di mezzi e non di risultato sono assimilabili alle prestazioni di natura intellettuale e procurano un ritorno economico collegato alle politiche attive per il lavoro ed alla posizione che l’agenzia del lavoro viene man mano ad occupare nel relativo mercato (tanto più rilevante quanto più numeroso è il personale che viene scrutinato e formato per una commessa e ricollocabile, perché non utilizzato o comunque somministrabile in future commesse).
L’arricchimento curriculare e la conquista o il mantenimento di nuove fasce di mercato e della correlata qualificazione economico-professionale, nonché il ritorno pubblicitario, costituiscono forme di remunerazione valutabili ai fini del giudizio di congruità dell’offerta (cfr., sul tema, anche Cons. Stato, V, 3 ottobre 2017, n. 4614, laddove si afferma che “[…] la ratio di mercato …, di garanzia della serietà dell’offerta e di affidabilità dell’offerente, può essere ragionevolmente assicurata da altri vantaggi [n.d.r. rispetto al prezzo corrispettivo dell’appalto], economicamente apprezzabili anche se non direttamente finanziari, potenzialmente derivanti dal contratto. La garanzia di serietà e affidabilità, intrinseca alla ragione economica a contrarre, infatti, non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale, che resti comunque a carico della Amministrazione appaltante: ma può avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, che nasca o si immagini vada ad essere generata dal concreto contratto”).
Peraltro, la pratica commerciale, che la stazione appaltante e la controinteressata assumono essere diffusa nelle gare di somministrazione di lavoro, di offrire una commissione (fee) di agenzia piuttosto bassa, per definizione non direttamente remunerativa, trova riscontro nella legge della gara de qua: era infatti vietata l’offerta di una fee pari a 0,00, con conseguente ammissibilità dello 0,01 (c.d. moltiplicatore a pareggio).
A quanto sopra consegue la non manifesta illogicità del giudizio di sostenibilità economica dell’offerta che ha tenuto conto dell’utile complessivo non coincidente col solo ricarico sul costo dei lavoratori somministrati.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui